La torre, il tarocco
della torre.
Cambiamento
epocale, distruzione, tabula rasa.
Il tarocco della torre
indica il sovvertimento radicale del
presente,
l’evento traumatico che fa deflagare le certezze. Il noto
si frantuma,
avanza l’ignoto. Ma anche l’inaspettato, la chance
d’un mutamento.
A ben guardare,
la storia della civiltà prevede sempre la costruzione o la distruzione d’una
torre e ciò coincide quasi sempre con momenti di critico passaggio. La torre è
emblema dell’ambizione, dell’ambizione degli uomini.
Ascendere verso
il cielo, in verticale, significa sfidare gli dei, portare affronto ai numi
tutelari. La torre ha preceduto di millenni l’avverarsi del sogno umano di
sollevarsi nei cieli. Mentre Icaro precipitava nei mari del mito per aver osato
sollevare la propria superbia verso il sole, le antiche civiltà popolavano il
mondo elevando solide torri a gradoni, spericolate dita di pietra rigirate
contro il regno degli dei giudici. La più nota di quelle meraviglie è passata
alla storia come Torre di Babele. Non sappiamo se Babele sia la gloriosa
Babilonia, capitale del regno immenso di Assurbanipal e di Nabuccodonosor.
Certo è che Babele e Babilonia sono nomi vergognosamente simili, anche se
Babele in aramaico significa confusione e Babilonia porta di Dio. Ma Babilonia
era una metropoli, antica e superba, trafficata da milioni di genti d’ogni
provenienza. Per cui, senz’ombra di dubbio, l’epiteto di confusionaria le si
addiceva di sicuro. Inoltre la torre di cui parla la Bibbia potrebbe
identificarsi con la grande Ziqqurat che si elevava nel centro della metropoli.
Una piramide
immensa, di gradoni che scalavano l’aria verso le stelle con fontane e
giardini. Essa offriva alla stirpe degli uomini la scala per giungere agli dei.
Ma se gli Dei
della Mesopotamia potevano apprezzare questa sorta di connubio con gli umani,
il Dio unico degli ebrei, che sarà poi lo stesso delle nostre religioni
moderne, era troppo superbo e ansioso per accettare un simile affronto, sicché
intervenne per interrompere l’erezione del bolide di pietra.
Libro della
Genesi, capitolo 11, versetti 1 – 9. “Tutta la terra aveva un medesimo
linguaggio ed usava le stesse parole. Or avvenne che gli uomini, emigrando
dall’oriente, trovarono una pianura nella regione del Sennar e vi si
stabilirono. E dissero l’un l’altro: ‘Su, facciamo dei mattoni invece che di
pietre e di bitume in luogo di cale.’ E dissero: ‘Orsù, edifichiamo una città e
una torre la cui cima penetri il cielo. Rendiamoci famosi per non disperderci
sulla faccia della terra’. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre,
che gli uomini costruivano, e disse: ‘Ecco, essi formano un popolo solo e hanno
tutti un medesimo linguaggio: questo è il principio delle loro imprese. Niente
ormai li impedirà di condurre a termine tutto quello che si propongono. Orsù,
scendiamo e confondiamo lì il loro linguaggio, in modo che non s’intendano più
gli uni con gli altri’. Così il Signore di là li disperse sulla faccia delle
terre ed essi cessarono di costruire la città, la quale fu chiamata Babel, perché
ivi il signore confuse il linguaggio di tutta la terra e di là li disperse su
tutta la terra.”
Se prestiamo fede
al mito biblico, dunque, dalla distruzione della torre di Babele ne deriverebbero
la confusione delle lingue, l’incomprensibilità, il non capirsi più.
La sciagura delle
intolleranze, la sconfitta delle lingue che, di tutti le convenzioni umane,
sono le uniche a erigere barriere fra gli esseri nascono allora, con quel
crollo. Non è forse vero?
Laddove la musica
affratella, la pittura ci raggiunge tutti, le architetture ci impressionano
senza badare alle nostre razze, le lingue, inesorabilmente ci dividono.
Da quella prima
erezione e da quel primo crollo, ne deriva dunque il primo, sommo male della
nostra storia.
Liquidiamo così
il mondo antico con le sue torri? Non diciamo nulla del grande faro di
Alessandria? La torre mastodontica che dalla testa dell’Egitto proiettava luce
ai quattro angoli del Mediterraneo? Una delle meraviglie del mondo. Architettura
sublime. Tecnica mai vista prima. La modernità nell'antichità!
L’immenso faro si
elevava sul fronte del porto di Alessandria, la città su cui Alessandro Magno
aveva posto il governo della dinastia dei Tolomei. Città di scambi e d’incontri,
profumata di spezie, adorna di scintille d’oro e lapislazzuli. La città della
più grande biblioteca dell’antichità. Migliaia di rotuli. In essa era
conservato tutto, assolutamente tutto il sapere del mondo antico. La sapienza
abitava ad Alessandria, vi aveva trovato un’accoglienza vasta e luminosa quanto
il faro della città. Ordinatamente disposta su scaffali di legno, dentro
corridoi silenziosi raggiunti dalle lingue, dai pensieri, dalle arti di tutte
le Terre allora conosciute, la scienza degli uomini era stata catalogata e
preservata sulle rime del Grande Mare dalle acque color del vino. Ma anche
quella doveva essere un’ambizione troppo grande per gli uomini. La sapienza,
come le torri, piace poco alle divinità. E nel Grande Mare della Porpora
viaggiante, abitavano dei rabbiosi e intolleranti. La biblioteca andò a fuoco,
trascinando con il suo sconfinato rogo tutta quella saggezza. Il faro, l’alta
torre della luce, si disfece tredici secoli dopo precipitando nel mare dove
ancora giacciono le sue millenarie pietre, scolpite da giganti. La caduta del
faro di Alessandria e l’incendio della biblioteca segnano la fine del mondo
antico: si prepara una tabula rasa della civiltà, un sommovimento di pensiero e
conoscenza. Il mondo entrò allora in una nuova stagione, cupa e diversa, che
del passato avrebbe salvato solo rovine e lacerti di sapienza.
.jpg)
Ciò nonostante,
l’uomo avrebbe continuato a erigere architetture verticali: i campanili e i
minareti! Lo fece per ingraziarsi quell’unico Dio, superbo, che era
sopravvissuto all’ecatombe del sacro del mondo antico. Quel dio che le torri le
distruggeva, accettò che a lui si elevassero come frecce del martirio le punte
acuminate di architetture traforate e austere.
Gli uomini erano
furbi, più furbi di lui, però.
Già, perché nella
selva di pietra delle città medioevali, accanto ai campanili ruffiani, sorsero
altre torri, centinaia, migliaia di torri. Emblema delle nuove classi, orgoglio
dei borghesi, visone concreta e tangibile della ricchezza dell’individuo. Eccolo,
nuovamente l’individuo, l’uomo che si impone, impone se stesso sugli altri e
primeggia, assalta la vita e la vince, teme Dio ma lo affronta sulla terra con
l’altezza della sua torre gentilizia.
S’alzano,
guardate, una dopo l’altra! Le innumerevoli torri d’Italia. Quelle di Pavia e
di Ascoli Piceno, scabre, ferrigne. Le due gemelle sottili di Bologna, la Ghirlandina di Modena,
il Mangia a Siena, il bosco di pietra di Lucca su cui campeggiano le torri
alberate dei Guinigi, ovunque sorgono, ovunque sfidano il cielo. Sfuggono l’asfissiante
reticolato di pietra e fetore delle città medioevali, uscendo dall’ombra della
paura per proiettarsi al sole, simili a missili, a falli spudorati, simili a
pugnali.
Ma il tempo segnò
la fine anche di quella stagione.
La stagione delle
torri.
Crollano per
incuria, s’accartocciano su se stesse, i gusti mutano e gli uomini le abbattono
per fare spazio all’aria, la ragione ripulisce le città. I profili
dell’orizzonte si sgomberano di questi puntaspilli lapidei che per secoli hanno
costellato i paesaggi.
Per lungo tempo,
per secoli, le torri scompaiono dalle pagine ingiallite dei progetti degli
architetti. L’uomo affronta il cielo con la scienza, brama il volo, chiede
elevazioni sempre più audaci. Ci provano i geni, costruiscono fallimentari
macchine destinate a voli abortiti: la vite volante, la nave volante, le ali
con stecche di balena… poi, nel secolo frivolo delle rivoluzioni e delle
parrucche, ecco che si fanno passi avanti. Si inizia a volare! L’uomo gonfia i
primi aerostati capaci di farsi più leggeri dell’aria elevandosi verso gli dei.
Madame e messieurs, venite, venite al gran volo dei fratelli Montgolfier!
Giunge a questo
punto, trascinata dall’elio e dai colori pastello delle Rivoluzioni, l’epoca
della modernità! Oh, sì, sì che giunge, il mirabolante XIX secolo! E
stranamente quell’antica urgenza di elevare al cielo architetture oltraggiose
rinasce.
Le metropoli
osano. Anche se i cieli ora sono percorsi dal volo sonnolento e maestoso degli
aerostati, le città devono dimostrare le loro ardimentose pretese. A Torino,
l’architetto Antonelli eleva entro il 1900 l’altissima, spericolata guglia
della sua mole. La mole Antonelliana sarà l’edificio in muratura più alto
d’Europa! 167 metri di sfida laica, un affronto se pensiamo che inizialmente
doveva essere una Sinagoga ebraica. Un affronto. L’umanità che si proclama
vincitrice della fisica. Un proiettile acuminato proteso a ferire il cielo di
Torino, quel cielo in cui passano ora le grandi mongolfiere, di fronte alle
Alpi solenni e innevate contro un cielo color carta da zucchero.
Non fu la mole
dell’Antonelli, però, la torre più ardita del XIX secolo. Quel tempo che ebbe
il sapore della sabbia e profumo di tabacco ebbe la sua superba ziqqurat.
È la tarda
primavera del 1889. Un grande evento! Alla corte d’Europa giunge il mondo
intero. La corte d’Europa, quell’anno, è la città di luce, Parigi.
Chiunque vi giunge,
la vede, immensa. Mai s’è visto un più ardito affronto al cielo. L’uomo ha
vinto, esalta a sua ascesa ed è egli stesso Dio! 6 maggio 1889. Apre la Grande Esposizione
Universale. I padiglioni sono pronti, si estendono come fantasie e capricci
sulla grande explanade. Ma su tutto campeggia Essa, la torre ferrata
dell’ingegnere Gustave Eiffel. 324 metri di altezza: 18.038 pezzi di ferro
forgiati, più di due milioni e mezzo di bulloni, 10.000 tonnellate di eleganza
che s’incurva verso il cielo. Enorme parafulmine, trionfo dell’ingegneria.
Anch’essa è un padiglione, l’emblema dell’Esposizione. Verrà tolta non appena
la manifestazione chiuderà, così ha deciso
la commissione organizzatrice. Poi le cose seguono un corso diverso e lei
rimane là, a dominare la metropoli per sempre. La modernità, il trionfo del
nuovo che avanza.

Ecco, immaginate ora di stare lassù, vicino
al fonografo installato da Edison sulla torre. Non occorre un aerostato per dominare
il mondo. L’emozione è incontenibile.
Ai piedi del
bolide ferrato, sui cui lati sono sati incisi i nomi dei luminari della scienza
e della tecnica della Grande Francia, si estende il mondo. Nei padiglioni,
minuscoli a guardarli da quell’altezza, si dipana una geografia globale: c’è
l’Italia, laggiù la Germania
vicino alle colonie della Persia, le ballerine Giavanesi, il Celeste Impero e
ancora il Giappone, le cui stampe ci portano l’aria di nuova bellezza,
rarefatta come un sogno.
Ecco le colonie
del Senegal, più in là il Siam, il Tonchino, la Bolivia, il Brasile e il
Venezuela!
Per un attimo
pensereste di volare, esattamente come nei romanzi di Verne. Compiere il giro
del mondo in un secondo dalla vetta della torre per farvi subito ritorno. Poi vi
svegliereste dal sogno. Scendereste a terra, passeggiando per quelle
meraviglie, fra gli immensi padiglioni dalle forme esotiche e bizzarre. Gli
architetti eclettici del tempo hanno mescolato tutto il mescolabile. Il risultato
è quantomeno bizzarro.
C’è qualcosa che
non va. La folla dei visitatori si appresta ai padiglioni esotici scrutandone i
figuranti, oriundi di terre lontane, come se fossero animali di uno zoo. È una
curiosità morbosa, che nasconde diffidenza e presunzione. Gli Europei sono
colonialisti, quella è loro merce. L’incanto delle ballerine di Giava è un
giocattolo per i borghesi, le loro movenze sono esotiche ma proprio per questo
pittoresche, persino pacchiane in quel contesto così lontano dal loro contesto.
Nelle architetture dei padiglioni si avverte già lo stereotipo, l’idea alterata
che dell’altra parte del mondo ci si fa in Europa ascoltando i racconti dei
viaggiatori, sfogliando i giornali, osservando le illustrazioni che deformano
la realtà e la riproducono agli occhi degli europei così come essi vogliono che
sia: inoffensiva, goffa, primitiva, ancestrale, infantile… li chiamano canachi.
Canachi. Sono gli
abitanti delle colonie, i rozzi ed ingenui abitatori di regioni che l’Europa
intellettuale e potente ha assoggettato e che sfrutta con abilità. La ricchezza
di Parigi dipende anche da quell’esproprio. Quella di Londra quasi
esclusivamente! Pensare che questa gente così diversa sia ingenua e rozza,
aiuta a non porsi il problema. Viene sfruttata, raggirata, dominata e i danni
di questo affronto non tarderanno a farsi sentire.
Molti non se ne
accorgevano. Per loro era normale. È questo un amle antico per l’Europa, non ha
mai saputo guardar oltre il proprio presente.
Ma poi il tempo è
andato oltre quel presente e si è visto come si svilupparono le cose.
Nell’esposizione di Parigi, che sembrò tanto meravigliosa ed eccitante, c’erano
tutti i germi del male. All’ombra della grande torre della presunzione, non ci si
accorse di cosa l’Europa stava facendo.
Non ci rendemmo
conto che ogni padiglione europeo sfoggiava la sua supremazia. Ogni Nazione si
preparava a rivendicare la sua identità, e quelle con più colonie, sembravano
godere di un prestigio maggiore. Non avremmo mai immaginato dove ci avrebbe
portato tutto questo…
Al buio.
Agli eccidi, alle
guerre. Eravamo al tramonto di un’epoca e nemmeno ce ne rendevamo conto.
Anzi! Pensavamo
così ingenuamente di essere sulla soglia di una nuova stagione della civiltà.
Ed invece…
E invece la torre
di ferro fu come un chiavistello che si rompe. Nessun Dio intervenne al momento
per punire quella superbia. I filosofi, in quegli anni, sostenevano che gli dei
erano caduti per sempre. Ma la punizione giunse, oh se giunse, e fu terribile,
terribile come era stato per la torre di Babele. La miriade di lingue che si contorceva
in un falso entusiasmo ai piedi della torre Eiffel, quella nuova Babilonia
fatta di lingue e dominio, avrebbe incappato nuovamente nella tabula rasa della
storia. La fine di tutto questo, se tutto questo ebbe una fine, sarebbe stata
56 anni dopo, su un’isola del Giappone. Una torre di fumo immensa, un fungo
senza precedenti. Lo sfiato mortale di una divinità corrotta che avrebbe
sancito, in modo irrevocabile, la sconfitta dell’umanità tutta.

Ma la storia non
si ferma. Non rallenta mai, anzi, tende ad accelerare. E dunque consacra nuove
torri, oppure le svelle. Il tarocco non sbaglia. Le tabulae rase, così dolorose
eppure care al tempo che scorre, sembrano davvero aver sempre a che fare con le
torri. Il gioco non si smentisce mai.
11 settembre 2011
Ed ancora
fatichiamo a capire. A guardare più avanti.
from 'Nimbus: l'amore ai tempi del vapore'


.jpg)






_by_William_Callow,_RWS.jpg)



















.jpg)


.jpg)


.jpg)

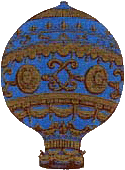







.jpg)